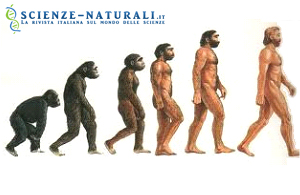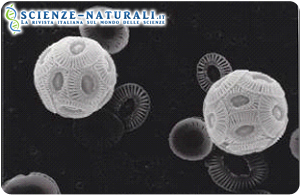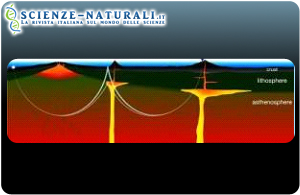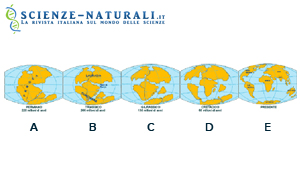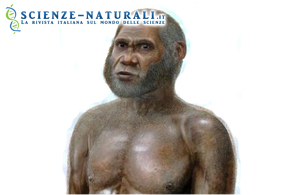Quando la stanchezza diventa una malattia. Il 12 maggio prossimo sarà celebrata, come è consuetudine da alcuni anni, la Giornata Mondiale della Stanchezza Cronica, il cui simbolo è rappresentato da un fiocchetto blu. Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa rara patologia, misconosciuta dai più, ma fortemente invalidante per chi ne è affetto.
Quando la stanchezza diventa una malattia. Il 12 maggio prossimo sarà celebrata, come è consuetudine da alcuni anni, la Giornata Mondiale della Stanchezza Cronica, il cui simbolo è rappresentato da un fiocchetto blu. Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa rara patologia, misconosciuta dai più, ma fortemente invalidante per chi ne è affetto.
Comunemente, una condizione di stanchezza è un sintomo, peraltro assai diffuso, cui ognuno di noi ha la propria risposta individuale in tempi variabili, ma che generalmente, dopo un adeguato riposo, ci restituisce alle condizioni ”normali” precedenti l’insorgenza dello stato di malessere. Spesso è solo un sintomo che spinge dal medico, il quale può verificare se alla base ci possa essere uno stato di stress psicofisico, una depressione, oppure una patologia organica quale l’ipotiroidismo, il diabete, un tumore o una malattia infettiva.
Niente di tutto questo riguarda la sindrome da stanchezza cronica, che si manifesta con una sintomatologia completamente diversa, non inquadrabile nelle patologie citate, con una gamma di disturbi legati a più malattie, per cui la diagnosi non può che essere fatta per esclusione. Non si hanno valori ematici alterati o una sola prova di laboratorio che possa essere utilizzata come indicatore diagnostico. Non esistono apparecchiature strumentali in grado di “misurare” la fatica, parametro di per sé soggettivo al pari della percezione del dolore.
Il paziente è “soltanto” stanco. Stanco come può esserlo una persona reduce da un lavoro manuale pesante. Affaticato per una stanchezza che non passa nè diminuisce anche dopo una notte di riposo.
All’astenia profonda si affiancano spesso dolorabilità diffusa agli arti e alle fasce muscolari, cefalea, febbricola, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, infiammazioni alla gola e linfonodi.
Questi disturbi possono insorgere anche separatamente e vengono spesso interpretati dal medico come disturbi della sfera psichica, generici stati depressivi o ipocondriaci.
E’ stato riscontrato che gli stati depressivi sono invece secondari, conseguenti allo stato di malessere diffuso, in cui il paziente riferisce di sentirsi “come dopo uno stato influenzale”. L’insorgenza della malattia è subdola ma improvvisa, quasi sempre dopo uno stato infettivo o un tumore o un forte choc come, ad esempio, un lutto. Si manifesta maggiormente tra la popolazione femminile, tra i 20 e i 50 anni di età, anche se è stato segnalato qualche sporadico caso nell’infanzia. Si è calcolato che in Italia 200-300mila persone siano affetti da questa sindrome, una cifra significativa, anche in senso sociale, qualora si metta in relazione con le ridotte capacità lavorative di chi ne è colpito e con il frequente assenteismo che necessariamente ne consegue. Purtroppo, ancor oggi, a fronte di migliaia di studi condotti un po’ovunque nel mondo, molti non conoscono affatto questa sindrome; in particolare, i medici. Anche se già dagli anni ottanta del secolo scorso si tentava di inquadrarne la sintomatologia, i criteri per una diagnosi di sindrome da fatica cronica sono stati codificati negli Stati Uniti, ad Atlanta, solo nel dicembre 1994 da un gruppo di studio internazionale, che ne ha anche stabilito la definizione in CFS (Chronicle Fatigue Sindrome), poi divulgata sugli Annals of Internal Medicine.
In Italia il primo ad accogliere i dati dei CDC di Atlanta e ad occuparsi di CFS è stato il prof. Umberto Tirelli, oncologo presso il CRO di Aviano. Attualmente, nel nostro Paese, oltre ad Aviano, esistono Centri per la diagnosi di CFS a Roma, Chieti, Pisa. Sempre ad Aviano, a Pavia e a Belluno si sono anche costituite Associazioni di ammalati, che si prefiggono di mantenere rapporti tra pazienti, promuovere la conoscenza di questa patologia e divulgare le eventuali novità che emergono dalla ricerca, ormai estesa in tutto il mondo, dagli USA al Giappone, dal Regno Unito al Belgio, al Sud Africa, all’Australia. Purtroppo i risultati ottenuti finora non sono molto confortanti. Nel 2007 Anthony Komaroff, professore di Medicina ad Harvard, ha riassunto alcune scoperte definitivamente accertate sulla CFS. Si sa che non si tratta di una forma di depressione. Nei pazienti è stato riscontrato uno stato cronico di attivazione del sistema immunitario e un aumento dei livelli di citochine. Utilizzando la risonanza magnetica, sono state notate anomalie nella materia bianca del cervello, in aree molto piccole della corteccia e differenze di volume della materia grigia. La tomografia computerizzata (SPECT e PET) ha rilevato anomalie del metabolismo cerebrale riferibili all’asse ipotalamico-pituitario-adrenalinico (HTA). Ricerche indipendenti hanno rilevato alterazioni nei geni che presiedono il metabolismo energetico, il sistema nervoso simpatico e il sistema immunitario.
Esistono prove di infezioni attive latenti da herpes virus (Epstein-Barr, HHV-6, citomegalovirus) ed entero virus. Per quanto riguarda la terapia, si sono purtroppo registrati passi falsi e sono state date spesso speranze infondate. Ricordiamo il fallito tentativo fatto con l’Ampligen, una decina d’anni fa, e nel 2009 la correlazione della CFS con il gammaretrovirus XMRV, accolta prima con leggero scetticismo e quindi smentita definitivamente nel gennaio 2012 da vari test che verificarono una contaminazione alla fonte. Ad oggi, la eziologia della CFS permane ignota e cure risolutive non ne esistono.
Ci si limita ad arginare i disturbi con somministrazioni di integratori, immunomodulatori, cortisonici. Un recente studio dell’Università dell’Iowa ha scoperto un legame biologico tra il dolore e la spossatezza che può aiutare a capire perché siano più le donne rispetto agli uomini ad avere diagnosi di dolore cronico in condizioni di fatica quali la sindrome da stanchezza cronica o la fibromialgia. Il dolore cronico e la fatica sono spesso associati. In persone affette da stanchezza cronica, ben tre persone su quattro hanno dolori muscolo-scheletrici diffusi rapportati alla fatica e ben il 94% delle persone con sindromi da affaticamento cronico segnalano dolori muscolari. Le donne costituiscono la maggioranza dei pazienti in cui è presente questa correlazione. Sperimentando sui topi, Kathleen Sluka, professore del Corso di laurea in Terapia Fisica e Scienza della Riabilitazione dell’Università dell’Iowa e Lucille A. Carter, del College of Medicine, hanno scoperto che una proteina, la ASIC3, coinvolta nel dolore muscolare, lavora in sinergia con l’ormone maschile del testosterone per proteggere contro l’affaticamento muscolare. “Abbiamo provato che la differenza nella fatica tra maschi e femmine dipende sia dalla presenza del testosterone che dall’attivazione della proteina ASIC3”, afferma Sluka. “Il risultato suggerisce che questi fattori stanno interagendo in qualche modo per proteggere contro la stanchezza e può aiutare a spiegare la prevalenza del numero di donne su quello degli uomini in condizioni di dolore cronico associato alla fatica”.
Lo studio, che è stato pubblicato sull’American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, indica che il dolore muscolare e la fatica non sono condizioni indipendenti e possono condividere un percorso comune. In un altro studio americano sulla CFS, i ricercatori, con opportuni test, hanno individuato risposte cerebrali diverse in pazienti affetti da questa condizione rispetto a soggetti sani, suggerendo una associazione tra risposta biologica funzionale e sindrome da stanchezza cronica. Lo studio è stato condotto da Elizabeth R.Unger, James F.Jones, Hao Tian dei Centers for Disease Control and Prevention; Andrew H. Miller e Daniel F. Drake della Emore University School of Medicine e Giuseppe Pagnoni dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I pazienti con CFS mostravano di avere una ridotta attivazione di un’area del cervello, i gangli della base sollecitati per una risposta alla ricompensa (Reward center).
I gangli basali del cervello sono associati, infatti, all’attivazione di una risposta alla ricompensa e le malattie di questa area cerebrale sono spesso associate alla fatica. L’esperimento è partito con la verifica che in pazienti affetti da epatite cronica C trattati con interferone-alfa in terapia immunitaria è stato trovato uno stato di affaticamento che ha molte analogie con la CFS. Pazienti affetti da CFS e individui sani sono stati sottoposti ad un test, un gioco con le carte in cui si vinceva una piccola somma di denaro. Con la risonanza magnetica è stato misurato l’afflusso di sangue ai gangli basali cerebrali durante le partite. Nei pazienti con CFS le differenze di afflusso sanguigno tra vincita e perdita era inferiore ai soggetti sani, così come pure il grado di stanchezza, inducendo a dedurre fosse presente una correlazione tra la fatica e queste variazioni. Unger afferma: “Molti pazienti con CFS incontrano molto scetticismo sulla loro malattia. Lo studio suggerisce che i gangli della base utilizzano dopamina, un neuro-ormone prodotto dal talamo e dai gangli della base. La dopamina è il principale neurotrasmettitore che agisce sul sistema nervoso simpatico, con effetti sulla frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Il meccanismo della dopamina può avere un ruolo fondamentale nella malattia e suggerire nuove vie di approccio alla cura. Lo studio, intitolato “Ridotta attivazione dei gangli basali in soggetti con sindrome da affaticamento cronico è associato ad affaticamento maggiore”, è stato presentato al meeting Experimental Biology 2012 presso il S.Diego Convention Center del mese scorso.
Leonardo Debbia